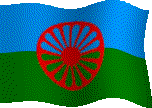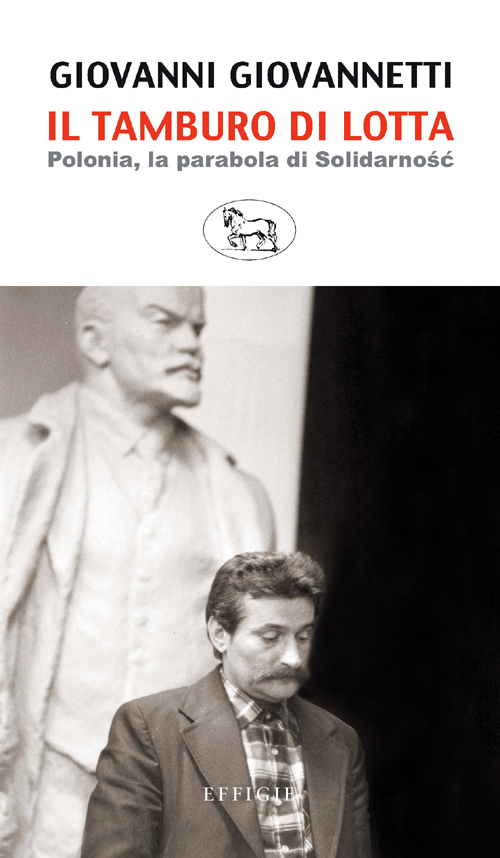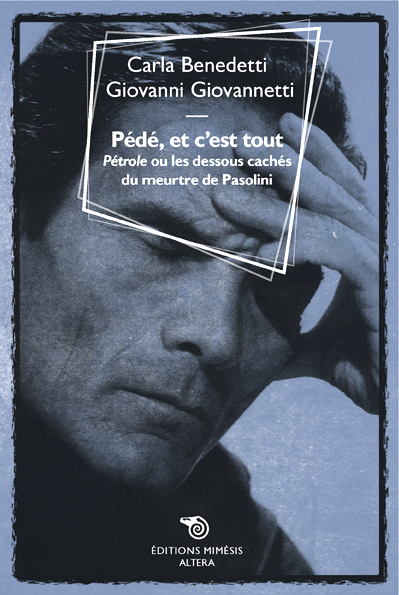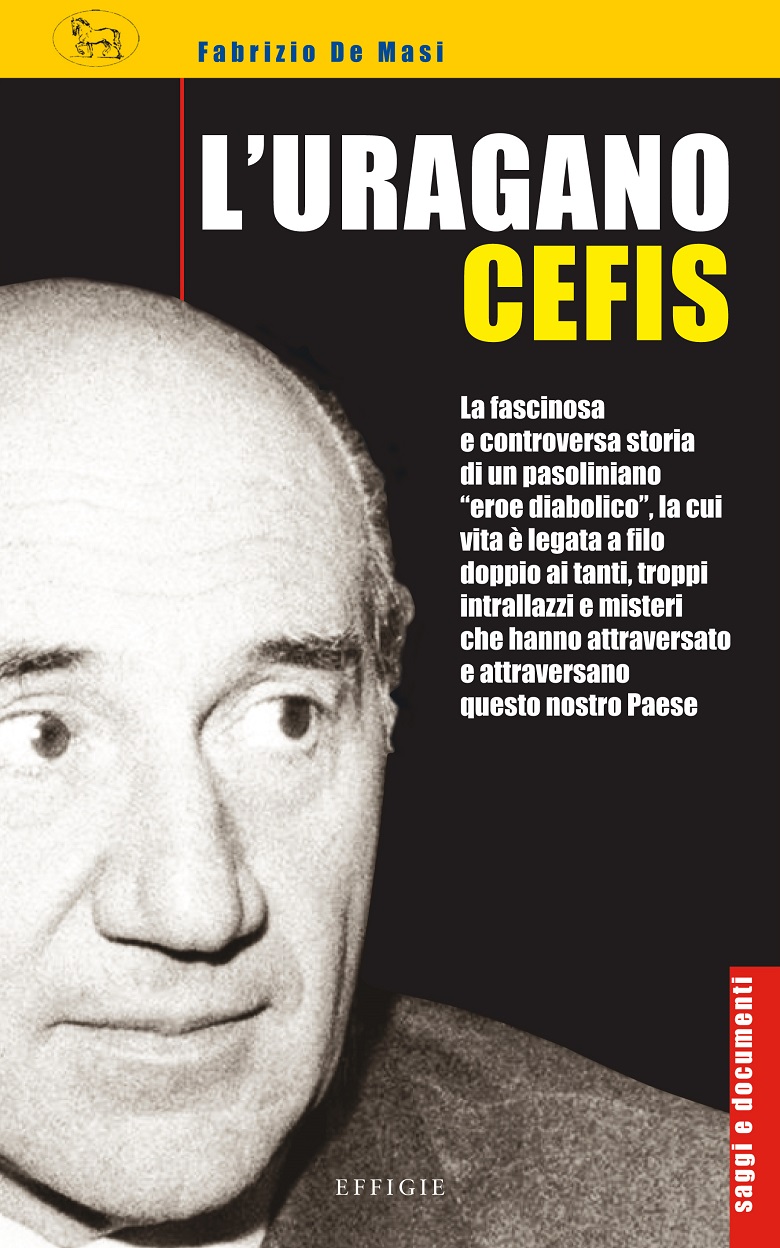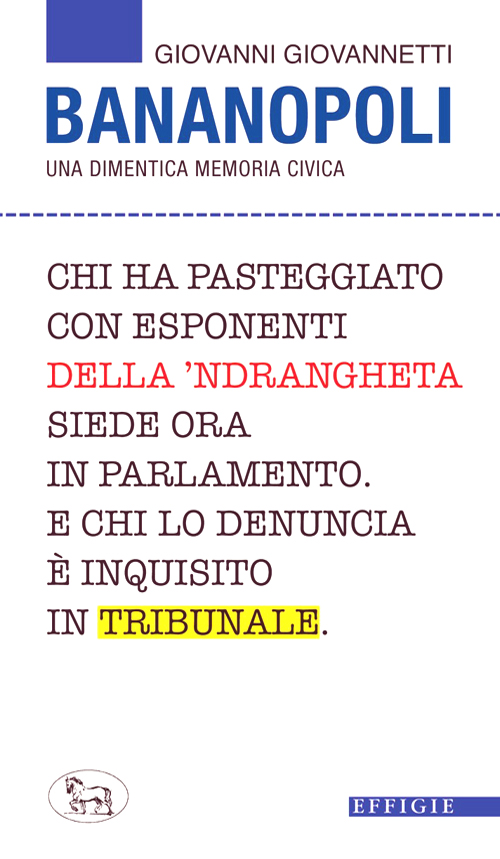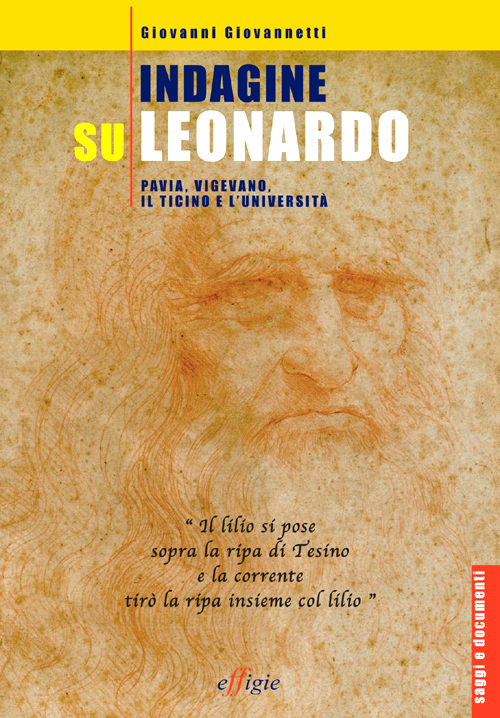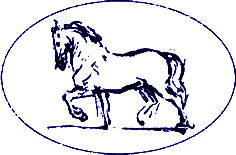Lettera a Antonio Moresco su Come una santa nuda di Alessandra Saugo
di Giovanni Giovannetti
Caro Antonio,
ho letto Come una santa nuda di Alessandra Saugo. Ero mosso da curiosità per l’ultima opera di questa autrice che proprio tu, tanto tempo fa, quando era al suo primo libro, mi sollecitasti a pubblicare.
Ero, lo confesso, anche un poco indispettito perché questo suo ultimo libro l’hai dato ad altri e non a me. In fin dei conti vent’anni prima l’ho pubblicata quando ancora nessuno la conosceva, e voleva. Poi, adesso, il nuovo libro l’ho letto e ho capito, purtroppo. Vado subito al dunque: le inaccettabili menzogne su di me e su altri che vi si leggono hanno avuto il tuo avallo, e questo mi ferisce ben più di quanto Saugo ha scritto.
E mi ferisce perché, al netto della voce«piena di céliniano furore» (come hai scritto nella tua recensione su “Tuttolibri” del 23 settembre scorso) e di qualche buona pagina, Come una santa nuda è un libro ingeneroso, falso e ignorante. Ingeneroso perché offende persone che l’hanno invece aiutata. Falso perché su di me ha mentito pur sapendo di mentire. Ignorante perché l’autrice avanza fantasiosi commenti sul mondo dell’editoria pur essendo digiuna di tutto ciò che pertiene al mondo del libro e dell’editoria.
Nondimeno, sul “Primo amore” l’incolpevole Giulia Della Cioppa lo recensisce spacciandola per «un’analisi di una lucidità impietosa, un testo che non risparmia nessuno e non dimentica niente»; un libro che «svela il rovescio della medaglia» di un mondo che «si presenta in tutto il suo livore, vaniloquente e remissivo» proponendo «una disamina critica dell’editoria che ovunque fa acqua, ovunque perde. Ovunque colpisce e punisce chi non sa stare nei canoni, punisce l’illeggibile, il difficile». Vedi, Antonio, che lettura può darne chi lo legge senza conoscere la verità? Senza cioè sapere – e ora parlo di me – che la «disamina critica dell’editoria» prende di mira unicamente il sottoscritto, ovvero colui che più di vent’anni fa l’aveva pubblicata, non rifiutata.
Scrive Saugo che il suo «primo e unico editore era indifferente, aveva lì un pezzo di ragazza, una trentenne in piena polpa, con questa lingua messa giù, con questa forza soul», e lui che fa? Lui, l’editore «resta indifferente a tutto. Non si accorgeva e non gli interessava niente», forse in attesa, butta lì Saugo, che il testo venisse ravvivato da qualche punta di erotismo. Del resto, il suo «psicologo dinamico lo dice sempre. Tutto sarebbe andato diversamente se ci fosse stato da qualche parte intorno al mio libro, davanti, di fianco, di sopra, di sotto, per dentro, per fuori, anche per dietro casomai, un grammo di erotismo. Con i passaggi freddi fanno poca strada le cantanti mute come me. Ero una giovane piacente cantante mummia. Non incontravo l’erotismo lungo la via. Ero l’epoca vittoriana con le gambe dei tavoli ricoperte dalla tovaglia perché non si accendano quei pensieri».
“Sarebbe andato diversamente” cosa? Quali “pensieri”? Io pubblico libri e non ho mai proposto a nessuno di intarsiare un’opera con inutili imbellettamenti. Ho avuto quel suo testo dalle tue mani, Antonio, l’ho letto e inserito così com’era nel piano editoriale. L’ho poi messo in pagina, salvo ricevere dall’autrice continue richieste di modifiche: voleva correggerlo e ricorreggerlo, anche dopo l’impaginazione definitiva, allungando i tempi di uscita in libreria.
Poi l’affondo si fa personale, con l’editore «sempre in affanno con quel pallore. E con quella dolcezza irrelata, sfasata, con quella sbadataggine di copertura all’insofferenza».
Eh sì, perché il suo psicologo, come «il fondatore della psicoterapia dinamica, aveva scritto che i cosiddetti filantropi o benefattori o Robin Hood», cioè io, l’editore, «erano in realtà i sadici autentici. E di controprove ce n’è purtroppo. E questo editore era proprio un filantropo. Tutte giuste cause edificanti, anche estreme. Cosa puoi dirgli. Tutte le ingiustizie soverchiavano le forze del bene dell’editore, le aizzavano. Tutto pieno di cattiverie intorno all’editore che doveva contestarle e doveva denunciarle. Come una carta moschicida era l’editore, e come le mosche erano le ingiustizie intorno a lui. Era romantico e pieno di ideali militanti, come un Che albino. Era avventuroso, era intrepido, era dalla parte del giusto. Chissà come mai però, in certe circostanze, come ad esempio le mie circostanze, invece cambiava del tutto, l’editore. E si trasformava in un’altra persona. E faceva come se un ecologista osservante, dentro a un bosco vergine, getta le sue lattine, getta i suoi rifiuti, sfregia il bosco vergine. E poi butta anche la tanica di benzina del suo gommone nell’indifeso azzurro mare».
Interrompo la citazione di Saugo solo per dire che colei che tracciava questo mio toccante ritratto io l’ho incontrata una sola volta, per pochi minuti, alla Palazzina Liberty di Milano a una lettura di poesie di Tomaso Kemeny. Ricordi, Antonio? Quella sera tu mi portasti da lei, seduta in sala. Un saluto e via. E dopo credo d’averle parlato qualche volta per telefono, con lei o con il marito.
Ma torniamo al «sadico autentico» avvertito da Alessandra Saugo e colto in castagna dal suo psicologo: «Gli psicologi dinamici chiamano questi misteri dell’animo umano degli editori e degli ecologisti manifestazioni residue. Esse tralignano sempre ogni animabellismo. A questo servono gli psicologi dinamici, a smascherare la bontà».
Caro Antonio, non hai nulla da dire sul «sadico autentico» qui dipinto? Sono così, io? Sai, quando a dire cose simili o a trinciare profili psicologici a distanza è una persona con qualche disagio, potrei anche soprassedere; ma da te che mi sei stato amico e sodale, da te che mi conosci e sai come stanno le cose, l’avallo della menzogna proprio no, non lo accetto.
Proseguiamo. Scrive Saugo di avere cercato le impronte digitali della mia bontà nella sua «cornetta del telefono sempre tumefatta dai suoi [dell’editore] schiaffi d’assenza». Più passava il tempo e più «le sue promesse da marinaio girovagavano orribilmente nella mia nave affondata come spettri, allora io avevo solo la sensazione che neanche un negriero era così sfacciatamente maleducato, privo di rispetto e impenitente. La pletora degli ideali umanitari di certa sinistra. Ma perché mai devo essere proprio io il precipitato di questa umanità dell’editore. Perché deve precipitare proprio nella mia vita la manifestazione residua di tutte di tutte quante le manifestazioni di estrema (bontà e solidarietà) sinistra. Perché devo vederne il volto capovolto, in particolare. Ma non voglio vederlo! Non voglio subirlo!, l’ho subito invece, e per tre lunghi anni».
Alessandra Saugo punta l’indice non sui tanti che il suo libro hanno cestinato, ma sull’unico editore che invece lo ha accettato e pubblicato, spendendovi tempo, soldi, energie. Dice poi di avere atteso la pubblicazione per tre lunghi anni. Non è vero. E comunque io fatico a pubblicare dieci libri l’anno, perché un piccolo editore ha forze limitate. Faccio quello che posso, ma ho molte opere in attesa e poche disponibilità economiche; di conseguenza capita, a turno, di dover aspettare, specie quando un autore è al primo libro.
«È stato un lavaggio del cervello subliminale. E mi sentivo indegna, piena di sensi di colpa verso l’editore, verso la sua ideologia e verso la sua militanza nel bene» perché, scrive Saugo, «io non sono una di loro, sono una casalinga figlia di un industriale tessile, con la rendita mensile come nell’800. La rendita mensile, capisci» [il corsivo è dell’autrice].
Per la verità io nulla sapevo della sua collocazione sociale o della sua situazione economica (solo ora, da questo libro, ho saputo che l’autrice era di famiglia altolocata e benestante); e comunque erano fatti suoi, estranei alla pubblicazione. Non di meno, secondo lei l’editore «mi punisce, mi disprezza magari, gli sono completamente indifferente. Dovrebbe occuparmi la casa il prima possibile, se fosse ancora tempo di moti. Se sapessi suscitargli un minimo di rabbia, di interesse, ma sono una che non interessa affatto, all’editore, una da preferirle un intero campo nomadi, piuttosto che la sua ignava buona educazione, che richiama, non richiamata. Una che non dovrebbe chiamare e che non dovrebbe richiamare, non dovrebbe mai telefonare e mai presentarsi da nessuna parte, a nessun appuntamento, per nessun motivo. E con qualcosa in mano mai e poi mai. Qualcosa di mantenuto. Quel manoscritto mantenuto non può essere lotta, corteo, bomba in bottiglia, urlo, denuncia, femminicidio, emarginazione, violenza, patriarcato, frode, sforzo sfegatato per non soccombere, per contestare, o contrastare, e vendicare e per proteggere, per custodire, restituire, risarcire, voler bene».
Ma come? Pur con forze limitate, pubblico il suo libro, ma il risultato è che vengo ricacciato nel solito stereotipo dell’editore di sinistra che, in quanto tale, boicotta tutto ciò che non è dichiaratamente “movimentista”? Alessandra Saugo conosceva l’articolato catalogo dell’editore di Effigie, presso cui ha pubblicato? Solo libri “militanti” e “di sinistra”? A questo punto domando: era il libro in ostaggio dall’editore, o era l’editore ostaggio di un libro, con la sua autrice che pretendeva corsie preferenziali?
«Ma posso dire tutto quello che voglio, tanto l’editore subodora, inconsciamente, pensando ad altro sempre e solo sorvolando, una oblomova. Che passa la sua giovinezza a non fare la rivoluzione, a non abbracciare nessuna ideologia, nessuna utopia, nessun fanatismo, neanche nessuna tossicodipendenza, neanche nessun adulterio, e neanche rave party, una senza storia, che non sa giusto niente. Ma no, no, all’editore non interessa neanche criticare, non interessa proprio niente, non legge neanche, non sente niente mentre gli parlo al telefono, non vede niente quando sono lì davanti a lui, non vede nessuno, non c’è nessun dialogo, nessun ascolto, è distratto fuori da ogni misura. Iuhuhu?!»
Caro Antonio, ero il suo editore, non suo marito, e tanto meno il suo confessore o il suo psicoanalista. Ma, dimmi, come ci si “difende” da autrici che, appena firmato il contratto, vorrebbero subito vedere il loro romanzo in libreria? E quando finalmente il libro esce, ecco Saugo lamentarsi perché questo suo romanzo «non c’è in nessuna libreria, l’editore non lo distribuisce, non c’è da nessuna parte».
Ah, «l’editore non lo distribuisce…» Secondo lei io spendevo tempo e quattrini nel fare libri per poi non distribuirli? Ecco, quando prima ho accennato all’ingenerosità e all’ignoranza del mondo editoriale e librario mi riferivo proprio a questo. E poi non sono io a distribuire i libri: non sono Mondadori, non dispongo di una autonoma rete distributiva; più del 50 per cento del prezzo di copertina se lo dividono la promozione e la distribuzione, esterne alla casa editrice. Ma stringi stringi è poi il libraio a decidere se tenere un libro oppure no: se i librai non ordinano un libro, l’editore non glielo può imporre. All’editore non resta che sostenere gli onerosi costi della promozione e della distribuzione pur sapendo che i libri intransigenti e diversi, come quello mio di Alessandra Saugo, faticheranno a farsi largo sugli scaffali. Ma vallo a spiegare a chi è digiuno di cose editoriali.
Caro Antonio, quando nacquero le edizioni Effigie tu mi fosti accanto, un generoso e prestigioso consulente che per noi distillava gli autori esordienti di valore: Toni Fachini, Paolo Mastroianni e Alessandra Saugo fra gli altri. A loro altri editori, ben più facoltosi, avevano detto no; io invece li ho pubblicati, mettendomi in gioco e mettendo un poco a rischio anche la casa editrice (gli esordienti sono una incognita, e possono recare affanno economico). Ma volevo dare voce a chi – prosatori, poeti e saggisti – aveva cose da dire e una forma per dirlo. E come editore, perché no, crescere con loro.
Antonio, tu c’eri. E poiché c’eri, come hai potuto avallare una così tracimante schiuma menzognera senza alcun commento, senza dotare il libro di una prefazione o di una postfazione? Perché licenziare Come una santa nuda senza uno straccio di contestualizzazione da parte tua? Proprio tu che nella vita e nell’opera hai tenuto il principio di verità come solido punto fermo.
Recensendola su “Tuttolibri” in forma di lettera, alla «Cara Alessandra» scrivi giustamente che questo suo “ardimento linguistico” «è uno scherzo pesante, pesantissimo» pieno di dolore e risentimento, un «tritacarne» in cui hai visto cadere anche alcuni tuoi «amici scrittori, che non meritavano tanto sarcasmo». Sono puntualizzazioni sacrosante, necessarie, che però avrei preferito leggere non su un giornale, ma da qualche parte nel libro.
Non lo hai fatto. E mi dispiace.